don Camillo Perrone "Parroco emerito di S. Severino L."

Fra i tanti problemi che attanagliano oggi il Paese, un posto preminente è occupato dalla dilagante disoccupazione giovanile. È un aspetto inquietante della nostra società, per i riflessi sociali e politici che esso pone. La Basilicata annaspa con un tasso di disoccupazione del 12,5%, che la relega all’ultimo posto anche tra le regioni meridionali. Dunque emergenza lavoro, spinoso e annoso problema.
In concreto ecco cosa si verifica: nel quarto trimestre 2016 sono state registrate 64mila assunzioni a tempo determinato e 19mila a tempo indeterminato. La precarietà del lavoro è una emergenza etica e sociale, che è in grado di minare la stabilità della società e di compromettere seriamente il suo futuro. La precarietà del lavoro non permette ai giovani di costruire una famiglia, con la conseguenza che lo sviluppo autentico e completo della società risulta seriamente compromesso.
La Chiesa sostiene, conforta, incoraggia ogni sforzo diretto a garantire a tutti un lavoro sicuro, dignitoso e stabile. È dunque la preoccupazione per la stabilità e la sicurezza del lavoro quella che spinge i pontefici ad esprimersi a favore dell’uomo.
Nella Basilicata la disoccupazione, specialmente quella giovanile, ha raggiunto livelli tali da non lasciare intravedere futuro tranquillo, fino a mettere in pericolo la stessa nobile tradizione di operosa e serena convivenza civile, forza e vanto del popolo lucano.
Per la Chiesa e per i credenti la lotta alla disoccupazione giovanile, alla mancanza di adeguate tutele, alle forti diseguaglianze è una vera e propria missione.
Viene spontaneo riallacciarsi alle parole di Papa Francesco dette nell’udienza del dicembre 2015 ai sostenitori del Progetto Policoro della Cei per i giovani disoccupati del Mezzogiorno: “Il lavoro non è un dono gentilmente concesso a pochi raccomandati: è un diritto per tutti”. Come insegna la dottrina sociale della Chiesa, il lavoro è un tratto distintivo della persona e non un accessorio, perché contribuisce a maturare la sua identità. Ecco perché la sua perdita e la sua mancanza vanno considerate un dramma.
Il lavoro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane: il lavoro ci dà la dignità! Chi lavoro è degno, ha una dignità speciale, una dignità di persona: l’uomo e la donna che lavorano sono degni.
Chi non lavora, dunque, non ha questa dignità. Ma ci sono tante persone che vogliono lavorare e non possono. E questo è un peso per la nostra coscienza, perché quando la società è organizzata in tal modo e non tutti hanno la possibilità di lavorare, di essere unti dalla dignità del lavoro, quella società non va bene: non è giusta! Va contro lo stesso Dio, che ha voluto che la nostra dignità incominci di qua.
I 36 anni che sono trascorsi dalla pubblicazione della Laborem excercens sono stati principalmente gli anni in cui si è manifestata la forza del processo di globalizzazione e quello che vive oggi l’Europa è il dramma della disoccupazione e della crescente precarietà del lavoro, le cui conseguenze si esplicano in una mortificazione dell’identità personale, in conflittualità sociali e, più in generale, in un diffuso pericolo per le stesse democrazie. Per affrontare il problema, la Chiesa propone il coinvolgimento non solo degli Stati, ma di tutti i soggetti sociali all’interno di una rete di solidarietà e di sussidiarietà. In particolare in questi ultimi anni ha proposto di incentivare, ad esempio, il mercato del lavoro attraverso la produzione di nuovi beni e servizi che valorizzano le risorse naturali, ambientali e culturali; di rendere più flessibili alcuni fattori produttivi, come l’orario di lavoro e i salari, senza mai cadere, però, nella trappola dello sfruttamento. Disoccupazione e precarietà minano il bene comune.
La Chiesa si adoperi perché tutti possano avere un lavoro e svolgerlo in condizioni di stabilità e sicurezza.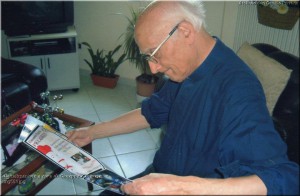
In conclusione, il nostro Paese ha una quota di giovani disoccupati tra le più alte in termini assoluti, nell’Unione Europea, e la maggiore percentuale di giovani che non lavorano né studiano. Non a caso il tema della prossima Settimana sociale dei cattolici in Italia (Cagliari, 26-29 ottobre) è “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale”. Tra gli obiettivi principali della Settimana, vi è la denuncia delle situazioni di sfruttamento, illegalità, precarietà, insicurezza e disoccupazione – specie al Sud e tra i giovani – e dei problemi legati al lavoro dei migranti.
Siamo dunque nel mezzo di un percorso che affonda le radici nel passato e si proietta nel futuro, con l’obiettivo di operare il bene comune, privilegiando le azioni che generano nuovi dinamismi. Ci guida la convinzione che le comunità devono assumere un ruolo pastorale sempre più centrale e propulsivo, perché “mentre l’ordine mondiale si mostra impotente ad assumere responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti.” (Papa Francesco, Laudato si’ 179)